È da tempo, ormai, che ho concentrato la mia indagine storiografica sul lessico comunista, dalle origini nel 1921 alla conclusione di quell’esperienza settant’anni più tardi. Nello specifico, sulla scorta delle ricerche anglosassoni della Lancaster University e di studiosi come Paul Baker, Norman Fairclough, e Ruth Wodak, il mio peculiare approccio storiografico ha unito all’analisi storica i vantaggi dell’analisi del discorso, qualitativa (Discourse Analysis) e quantitativa (Corpus Linguistics), attraverso l’uso di software lessicometrici come AntConc, Concordance, WordSmith, e TreeCloud.
Tale indagine ha visto il raggiungimento, tra le altre cose, di due importanti risultati. Nel volume uscito per i tipi di Viella nel 2019, ricerca già vincitrice del premio EUT–2017, ho indagato il rapporto tra “partito” e “popolo”, come cioè il PCI ha costruito retoricamente non solo la propria militanza, ma anche l’intero complesso dei cittadini nel volgere degli anni e delle stagioni politiche [Non è solo questione di classe. Il “popolo” nel discorso del Partito comunista italiano (1921–1991), Roma, Viella, 2019]. La mia seconda monografia, uscita l’anno successivo con la University Press di Parma, ha invece spostato la lente sul vertice PCI, ricostruendo il complesso percorso di definizione discorsiva e di affermazione simbolica della leadership comunista nei centrali anni compresi tra le origini, alla fine degli anni ’10, e la morte di Togliatti, a metà dei ‘60 [La formazione della leadership comunista tra “utopia” e “compromesso”. Dalla nascita del partito al Memoriale di Yalta (1917–1964), Parma, Athenaeum, 2020].
Studiare il Partito Comunista Italiano da un punto di vista della sua retorica, del suo vocabolario, delle sue parole anche attraverso gli strumenti delle Digital Humanities — tutte questioni collegate e a un tempo distinte — è sicuramente valso a illuminare aspetti che non erano ancora stati sondati; questo perché, generalmente, la storiografia sul comunismo e sui comunismi, salvo debite eccezioni, ha in genere privilegiato indagini di tipo politologico e sociale. Oggi più che mai, nell’anno del centenario, reputo allora fondamentale l’apertura di un dibattito e di un confronto scientifico centrati non soltanto sul medesimo oggetto di studio, il partito comunista, ma anche sui diversi approcci e sulle diverse prospettive di analisi.
***
Questo breve scritto, a partire dal mio lavoro per Viella, intende approfondire gli aspetti metodologici della mia ricerca, esporne i principali risultati, e proporre insieme, in riproduzione, una piccola galleria “museale” dei materiali indagati.
Partirò proprio da quest’ultimo aspetto, e cioè dalle principali fonti indagate. Nucleo fondamentale della mia ricerca è il discorso pubblico del partito; ho affiancato pertanto le consuete fonti “interne”, come i verbali di segreteria, le circolari di sezione, i materiali congressuali e così via, con una lunga, capillare, paziente indagine sulla stampa di partito, canale di comunicazione politica e di diffusione propagandistica per eccellenza.
Più specificamente, ho innanzitutto analizzato la stampa socialista e comunista dei primi anni ’10 e ‘20, e in particolare i settimanali «Il Grido del Popolo», «Il Soviet», «Lo Stato operaio» e il periodico torinese «L’Ordine Nuovo». Tuttavia, base privilegiata della ricerca è stata l’analisi dell’intero corpus dell’edizione nazionale dell’organo comunista, grazie anche alle possibilità fornite dall’archivio storico digitale de «l’Unità», che consentiva di effettuare ricerche per parole chiave, proprio come “popolo”, e di verificarne le occorrenze. In questo modo ho potuto consultare interamente il quotidiano, dal 1924, data di fondazione del giornale, al 1991, anno di scioglimento del partito, con particolare attenzione per gli anni compresi tra il 1944 e il 1976.
Presso gli archivi–emeroteche delle Fondazioni e Istituti Gramsci, tra cui quello toscano, e degli Istituti storici della Resistenza, ho poi indagato i principali periodici e rotocalchi comunisti: dalla rivista teorica «Rinascita» al giornale clandestino «La Nostra lotta», dal rotocalco «Vie Nuove» a un periodico settoriale come «Noi donne». Ho inoltre approfondito alcuni aspetti legati alla politica culturale, soprattutto per gli anni ’50, indagando riviste come «Il Calendario del Popolo», «Il Politecnico», «Società», «Realismo», o «Il Contemporaneo». Anche le riviste dedicate al mondo sovietico, come «La cultura sovietica», «Rassegna sovietica», e soprattutto «Realtà sovietica», sono state una fonte essenziale per la mia ricerca, che non ha mancato di guardare alla stampa per i più piccoli («Il Moschettiere», «Il Pioniere dei ragazzi», «Pioniere», «il Pioniere», «Pioniere Noi donne») e a quella per ragazzi e giovani adulti («Noi ragazzi» e «Nuova generazione»).
D’altra parte, un prezioso materiale di indagine si è rivelata la consistente stampa di organizzazione, materiali ricchissimi di informazioni ma scarsamente indagati dalla storiografia di settore: dal «Bollettino di Partito» al «Quaderno dell’attivista», creato ad hoc per il triplo appuntamento elettorale del 1946, dal «Quaderno del propagandista» a «Propaganda» e al «Taccuino del propagandista».
Lo studio di queste fonti attraverso il mio peculiare approccio misto di analisi storica della retorica politica ha portato a individuare nei testi prodotti dal partito alcune regolarità narrative intorno alla questione del “popolo”, rilevandone le persistenze o al contrario i cambiamenti lungo il corso dei decenni. Vediamo dunque quali.
Passando alle questioni più prettamente analitiche, dobbiamo innanzitutto premettere come, a partire dalle grandi rivoluzioni del XVIII secolo, dai moti della prima metà del XIX, e da esperienze come la Comune parigina nella seconda metà del secolo, la contemporaneità si sia dovuta in qualche modo misurare col discorso sulla collettività. Infatti il popolo, potremmo dire, è divenuto in queste date l’istituto supremo delle democrazie e il riferimento sociale dell’architettura politica della modernità. In questo contesto e in questo processo, il marxismo sembrava aver costituito un’eccezione, visto che la riflessione marxista ha espunto proprio il popolo dal centro della propria analisi, parlandone semmai indirettamente. D’altra parte, nel cuore del marxismo batteva semmai la classe operaia, la cui azione salvifica distingueva la lontananza politica e anche morale tra “la parte” e “il tutto”: la “classe per sé”, l’avanguardia consapevole del proletariato, e la “classe in sé”, il popolo, la massa, la moltitudine indistinta da guidare.
Date queste premesse, scopo della mia indagine è stato quello di indagare come il comunismo del XX secolo, e in particolare quello italiano, si sia posto davanti a questo nuovo soggetto politico, come abbia guardato al “popolo” un movimento che traeva le proprie origini e la propria identità nella filosofia marxista.
Certamente, per tutti gli anni ’10 e per almeno tutti gli anni ’20, la retorica dei leader e futuri leader comunisti italiani è stata completamente permeata del dualismo e della classica gerarchia del discorso marxista. In questo lasso di tempo, infatti, la parola “popolo” compariva solo in stretta misura, oltretutto in un’accezione generica, nel suo significato di “relativo al popolo”, “diffuso nel popolo”; non un soggetto, quindi, ma uno “spazio sociale”, se così possiamo dire.
In casi per lo più eccezionali, il lemma assumeva un senso più prettamente politico. L’accezione valoriale data al termine nella maggior parte dei casi era negativa, come massa eterogenea e ignorante. Un «popolo arretrato ed opaco», nelle parole di Antonio Gramsci su l’«Avanti!» alla fine del 1918, «percorso da stimoli irrazionali e capricciosi, assente da ogni lotta ideale ed economica avente caratteri organici di necessità permanente» (I cattolici italiani, in «Avanti!», edizione piemontese, 22 dicembre 1918). A volte, però, prendeva un significato positivo, nella sola eccezione della celebrazione del popolo sovietico rivoluzionario; si prenda come esempio ancora un articolo di Gramsci, uscito su «L’Ordine Nuovo» qualche mese più tardi: «La Rivoluzione russa ha pagato la sua taglia alla storia, taglia di morte, di miseria, di fame, di sacrifizio, di volontà indomata. Oggi il duello arriva al suo culmine: il popolo russo si è levato tutto in piedi, gigante terribile nella sua magrezza ascetica, dominando la folla di pigmei che furiosamente l’aggrediscono» (La taglia della storia, in «L’Ordine Nuovo», 7 giugno 1919 [FIGG. 1–2]).


Come noto, la classica interpretazione della dottrina marxista prevedeva che fosse compito dell’avanguardia comunista e della classe operaia incanalare le caotiche energie del popolo in una disciplinata azione rivoluzionaria. Del resto, nei primi anni di vita, il Partito Comunista d’Italia concepiva sé stesso come il “partito dei proletari”, ”dell’economia socializzata”, o “della classe operaia”, per citare solo alcuni dei tanti epiteti de “L’Ordine Nuovo”, sino a che, nella seconda metà degli anni ’40, cominciò a definirsi sempre di più come “partito del popolo”.
Alla metà degli anni ’20, sulla stampa di partito cominciò a comparire sporadicamente l’endiadi “popolo lavoratore” in una posizione — morale, politica, e sociale — più elevata del popolo nel suo insieme, ancora rappresentato come “blocco amorfo”. L’uso delle parole non è mai casuale, e semmai è causa e prodotto delle trasformazioni politiche, sociali, ed economiche. Certo, il popolo connotato con questa accezione aveva ancora un’incidenza sporadica in termini di occorrenze, ma ciononostante questa deve essere messa in relazione con il consolidamento e la statualizzazione del fascismo. Tra il 1919 e il 1920, scriveva Gramsci su «L’Ordine Nuovo» dell’aprile 1924, «la forza politica del proletariato consisteva nel trovarsi automaticamente alla testa di tutto il popolo lavoratore, nel centralizzare obbiettivamente [sic] nella sua azione diretta e immediata contro il capitalismo tutte le rivolte degli altri strati popolari, amorfi e senza indirizzo» (Problemi di oggi e di domani, in «L’Ordine Nuovo», 1–15 aprile 1924 [FIG. 3]).
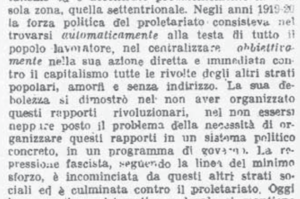
In pratica, col suo grido di riscossa, diceva Gramsci, il popolo lavoratore italiano diveniva sinonimo delle masse oppresse e sfruttate prima dal capitalismo e dalla borghesia, poi anche dal fascismo.
Tuttavia, la vera e propria svolta retorica arrivò alla metà degli anni ’30, come prodotto e a sua volta riproduttore di una fondamentale svolta politica. Ma procediamo con ordine.
La parola “popolo” si era imposta nel lessico comunista innanzitutto in URSS, con la stabilizzazione del sistema sovietico. Il popolo era infatti stato soggettivato come insieme organico delle nuove classi della società sovietica mentre la nuova Costituzione del 1936 aveva fatto coincidere “popolo sovietico” e “stato rivoluzionario”. Si tratta dunque di un classico esempio di circolazione di idee e di connessione (co–evoluzione? reciproca influenza?) tra il linguaggio del comunismo italiano e quello sovietico, tra la politica estera di Mosca e la strategia di lotta dei partiti comunisti europei. In effetti, nella seconda metà degli anni ’30, il discorso sul popolo si affermò poi in tutto il movimento comunista internazionale come narrativa dell’unità delle forze progressiste con la stagione dei “fronti popolari”.
Nella prospettiva politica della lotta al nazi–fascismo, il PCI cominciò quindi a rivolgersi non tanto alla classe, quanto direttamente (se non esclusivamente) al popolo, modificando in maniera significativa — rivoluzionaria, si potrebbe dire — la propria retorica e la propria concezione del mondo. Prendiamo come esempio Togliatti. Tra gli anni ’20 e i primi anni ‘30 nel vocabolario togliattiano l’uso del termine era scarso, sulla scorta di un lessico direttamente connesso ai codici del linguaggio dell’ideologia comunista. Al cuore narrativo vi era semmai la classe, come «elemento che si organizza, che acquista una coscienza, che “vuole” e fa pesare la sua organizzazione su tutto il processo della trasformazione sociale», spiegava sull’organo di partito (La nostra ideologia, «l’Unità», 221, 23 settembre 1925). Quando presente, “popolo” era perlopiù utilizzato per specificare un’appartenenza in partizione (nel senso di “popolo contadino”, “delle città”, “delle campagne”, e così via), equivalendo all’uso più comune del lemma “mondo” (nel senso di, per esempio, “mondo contadino”). In questo modo, nei testi e nei discorsi di Togliatti, la parola non compariva mai per indicare totalità, come insieme dei cittadini, non era mai intesa in senso patriottico, come sinonimo di nazione, né era mai il destinatario degli appelli diretti. Invece, tra il 1935 e il 1945, da un punto di vista quantitativo, se il primo sostantivo a comparire nella nuova word–list delle occorrenze era “Italia”, il secondo era proprio “popolo”, mentre “classe” scendeva al centoventunesimo posto delle parole più usate. Non sono dati da poco.
Tali cambiamenti non riflettevano solo un dato quantitativo; sono infatti altrettanto e più importanti gli aspetti qualitativi del discorso. Questo è particolarmente evidente analizzando la stampa e la produzione propagandistica del PCI rilasciata tra il 1943 e il 1945, non a caso in concomitanza con i grandi avvenimenti internazionali, quali la “grande guerra patriottica” sovietica e lo scioglimento del Komintérn, in patria, con la riorganizzazione (tutt’altro che nominale) del Partito Comunista d’Italia in Partito Comunista Italiano e la “svolta di Salerno”. Attraverso la retorica della Resistenza, il popolo acquisiva infatti un’importanza e un significato completamente nuovi: da elemento assente, sotto–rappresentato o tutt’al più immaginato come una moltitudine eterogenea priva di scopo a popolo consapevole, attivo, orientato, dotato di capacità performativa e nuovo motore della storia comunista (Il popolo italiano arriva alla Vittoria, in «Il Calendario del Popolo», 5, 16–31 maggio 1945 [FIG. 4]).

Da un punto di vista della semantica storica, questo cambiamento può essere apprezzato da diversi punti di vista e in particolare nella reiterazione di alcune associazioni semantiche. In primis “tutto il popolo” e il “popolo italiano”, che devono essere interpretati come elementi fondamentali di una costruzione retorica che univa narrativamente elementi populisti e nazional–patriottici (si veda per esempio l’articolo Tutto il popolo sotto la bandiera della democrazia, in «l’Unità», 7, 9 gennaio 1946 [FIG. 5]).


Queste due grandi narrazioni rispondevano infatti ad almeno due basilari esigenze politiche: la necessità di rendere il PCI un grande partito, nazionale e di massa (il “partito nuovo” togliattiano); e la necessità della transizione e della ricostruzione, una ricostruzione politica, innanzitutto (nella formula della “democrazia progressiva”). In poche parole, sul popolo — sul discorso sul popolo, chiaramente — si giocava il fondamentale passaggio da una politica classista, rivoluzionaria e internazionalista alla nuova linea politica, interclassista e pluralista, democratica, nazionale.
Esempi importanti di questa rinnovata retorica comunista possono essere rintracciati principalmente negli appelli comunisti durante l’ultimo anno di guerra e soprattutto nelle prime campagne elettorali, come mostrano bene le elezioni del 1946, del 1948, e del 1953 (un esempio, per il 1953, nella vignetta di Majorana, Voto popolare, in «Vie nuove», 25, 21 giugno 1953 [FIG. 6]).

Sin dal 1945 e particolarmente in queste occasioni, il popolo era onnipresente sulla stampa o nei grandi discorsi pubblici dei dirigenti, Togliatti per primo, dove venivano reiterati peculiari locuzioni e costrutti: “volontà del popolo”, “esigenze del popolo”, “attese del popolo”, “in nome del popolo”, e così via (un esempio in L’aspettazione del popolo non deve andare delusa, in «l’Unità», 111, 13 maggio 1945 [FIG. 7]).

Sul popolo, del resto, erano propagandisticamente fondati i due cartelli elettorali siglati coi socialisti tra il 1947 e il 1948, il Blocco del Popolo e ovviamente il Fronte Democratico Popolare, denominazioni che ormai non appariranno più casuali [FIG. 8].

Il “popolo” rimase l’architrave della narrazione comunista anche negli anni successivi e per tutto il ventennio compreso tra la fine degli anni ’40 e la fine degli anni ’60, base stessa nella concezione comunista della ricostruzione dell’Italia, come mostra bene il notevole manifesto della federazione comunista di Modena: «con il popolo, per il popolo» [FIG. 9].

Il popolo era infatti la chiave di volta della stessa auto–rappresentazione del partito e della stessa dirigenza. In primo luogo, infatti, il PCI si presentava ormai principalmente come “partito del popolo”, a volte anche con le iniziali di “partito” e “popolo” in maiuscolo; nelle parole di Teresa Noce sul quotidiano: «Il V Congresso Nazionale del Partito Comunista non è stato solo una prova di grande maturità politica e di forza nazionale organizzata. Esso è stato anche la dimostrazione concreta che il Partito Comunista è, e si avvia a diventare sempre più, un vero Partito del Popolo, il Partito della solidarietà nazionale» (Estella, Il partito del popolo e della solidarietà nazionale, in «l’Unità», 9, 11 gennaio 1946). Allo stesso modo e in secondo luogo, il “dirigente di tipo nuovo” e il “candidato” del partito di massa togliattiano dovevano presentarsi come “l’uomo popolare”, vicino al popolo (Il candidato deve farsi conoscere dal popolo, in «Quaderno dell’attivista», settembre 1948 [FIG. 10]).

Indubbiamente, gli anni ’50 sono stati gli anni di maggior radicamento della struttura organizzativa del PCI sul territorio nazionale e in parallelo di consolidamento della componente ideologica comunista nella società italiana. Tra le operazioni retoriche e politiche di questo grande rafforzamento, un ruolo di primo piano ha avuto la “popolarizzazione” che, se non è stata una parola d’ordine ufficiale, è stata però una vera e propria direttiva politica legata alla massificazione del partito. “Popolarizzare” la linea del partito, spiegava il maggior rotocalco del PCI, significava “mobilitare il popolo”, un’operazione che richiedeva al partito e alla dirigenza di “essere costantemente in mezzo al popolo con la parola, con l’esempio e con le azioni” (Questioni del popolo. Questioni del partito, in «Vie nuove», 26, 27 giugno 1948 [FIG. 11]).
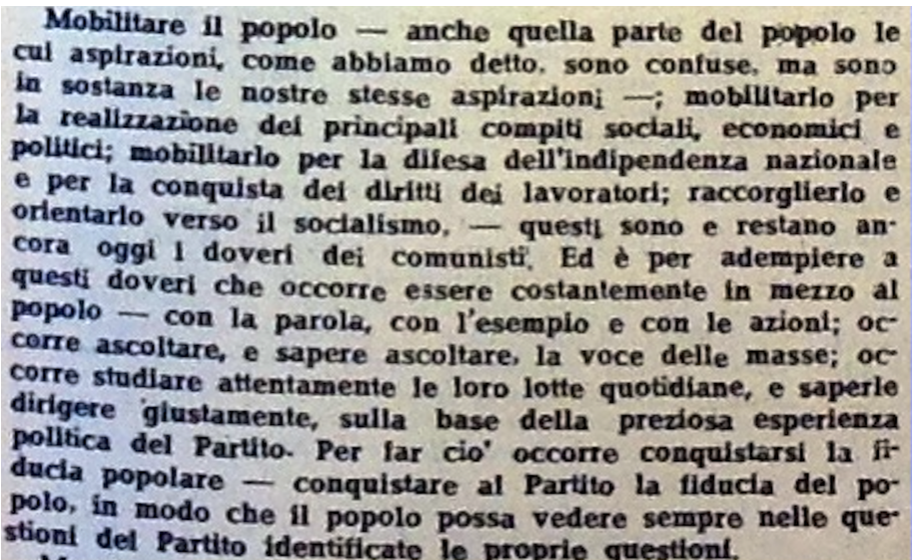
In pratica, significava fidelizzare i simpatizzanti, coinvolgere la cittadinanza nelle iniziative del partito, capillarizzare i canali di comunicazione politica; secondo l’adagio, costruire “una sezione per ogni campanile”. Tale operazione doveva essere portata avanti attraverso tutta una serie di elementi: il complesso sistema delle scuole di partito; la stampa e l’editoria, le cui testate venivano continuamente ristrutturate e aumentate; il lavoro nelle sezioni e nelle federazioni e l’organizzazione del tempo libero grazie alle case del popolo, alle feste de l’Unità, e alle tante altre iniziative sociali; ovviamente la Fondazione Gramsci di Roma e, più tardi, la rete degli Istituti Gramsci. Anche la politica culturale fu concepita retoricamente sul “popolo”: l’arte, spiegava Togliatti, non poteva essere arte se non era espressione del “popolo” e “al servizio del popolo” (un esempio di tale narrativa in Renato Guttuso, Che cosa vogliamo dalla pittura?, in «Vie nuove», 30, 24 luglio 1949 [FIGG. 12 e 13])


D’altra parte, e non è un dato da poco, proprio la coerenza e l’ampiezza con le quali fu portata avanti la popolarizzazione sono in grado di spiegarci la posizione di indiscussa egemonia sulla sinistra mantenuta dal PCI per oltre trent’anni.
Certo, il 1956 ha costituito un indubbio duro colpo per il comunismo internazionale, che tuttavia non scalfì questa impalcatura retorica. La nuova linea politica, lanciata nel dicembre all’VIII Congresso, riconosceva il policentrismo del sistema socialista, una posizione suffragata dal consolidamento della Repubblica Popolare Cinese. La pluralizzazione e la diversificazione dei sistemi socialisti presupponeva il riconoscimento della possibilità di un’avanzata verso il socialismo con caratteristiche differenti rispetto a quelle del primo stato socialista, fondate sulla specifica storia del paese e sulle particolari esigenze del proprio popolo. Il popolo italiano e le sue specificità fungevano dunque, ancora una volta, da fonte di legittimazione per la svolta politica imboccata dal partito. Del resto, pochi anni dopo, con l’occasione delle agitazioni operaie del luglio 1960, sulla stampa di partito il popolo tornava alla ribalta nella retorica del popolo italiano antifascista in lotta contro le forze reazionarie e clericali, mentre la stessa concezione standardizzata del popolo veniva utilizzata per interpretare e descrivere tutte quelle forze variamente impegnate nei processi di decolonizzazione (Gianni Toti, L’Africa ha detto Diotsarev, in «Vie nuove», 50, 20 dicembre 1958 [FIG. 14]).

Tuttavia, questo tipo di narrazione dicotomica e la costante riproposizione di alcuni termini specifici (come “popolo”) e narrazioni (antifascismo, Resistenza, reazione) hanno man mano costruito un linguaggio idiomatico che ha sempre meno intercettato ed è sempre stato meno in grado di descrivere la complessa società del benessere e i processi di differenziazione sociale della modernizzazione. Ancora sul popolo era incentrata la strategia politica del “blocco di forze sociali”, popolari e di ispirazione democratica, alla base della politica del compromesso storico del nuovo segretario Enrico Berlinguer.
Soprattutto durante gli anni ’70, però, gli anni del movimento studentesco, delle lotte operaie, della sinistra extra–parlamentare e del femminismo, il discorso sul popolo finì per avvitarsi velocemente su sé stesso. D’altra parte, il completo abbandono di questa retorica, negli anni ’80, e l’indirizzo politico verso una fetta sempre più minoritaria della popolazione — quella che sarebbe stata chiamata la “società civile” — ha giocato in chiave contraria, aumentando vertiginosamente le distanze tra partito ed elettorato. Fornisce un chiaro esempio di questo completo abbandono del popolo ancora una volta la stampa di partito, per l’occasione dei funerali di Berlinguer. Su «l’Unità» del 14 giugno 1984 gli appellativi variavano da «tutti», «gente», «enorme piazza», «immensa folla», «mille voci di dolore e di speranza», «sterminato corteo», «marea di uomini giusti», «tutta la città»; pochissimi, invece, i riferimenti al popolo. Il percorso è particolarmente lampante se si confrontano gli articoli che, venti anni prima, avevano celebrato la morte di Togliatti, quando il popolo era stato protagonista indiscusso della commemorazione e del racconto su di essa (Il popolo onora Palmiro Togliatti, «l’Unità», 227, 23 agosto 1964; L’ultimo saluto dato a Enrico Berlinguer, «l’Unità», 140, 14 giugno 1984 [FIGG. 15 e 16]).


In conclusione possiamo chiederci: che cos’è stato dunque il popolo per il PCI?
Molte cose, potremmo brevemente rispondere: spina dorsale, cartina di tornasole di un difficile processo di trasformazione ideologica e politica, adattamento e contribuzione al consolidamento democratico. Ma anche parola che nasconde, tra le righe, il grande lavoro del partito nella costruzione di un popolo, quello italiano, dagli anni ’40 e per un trentennio costantemente identificato come il soggetto protagonista dell’azione politica e dell’edificazione della democrazia repubblicana.


